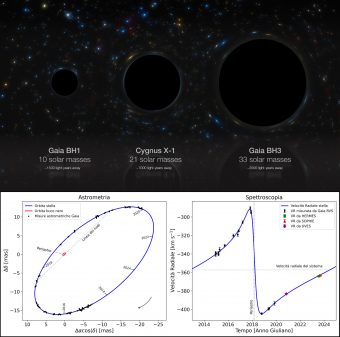Le texte suivant reproduit l’intervention du directeur d’”Eurasia” au colloque sur Jean Parvulesco qui a eu lieu à Paris le 23 novembre 2012.
Ma première rencontre avec le nom de Jean Parvulesco date du 1974, quand j’étais l’objet d’attention des mêmes juges italiens qui, dans le cadre d’une enquête politique, s’intéressaient aussi à ce mystérieux roumain lequel appelait à être prêt pour le Endkampf (un mot très suspect aux yeux des chasseurs de sorcières, qui, dans leur orthographe, devenait endekampf) (1).
Selon les enquêteurs, le roumain aurait voulu réaliser, avec deux des accusés, un accord fondé sur deux points: “a) adhésion à la politique de lutte internationale contre le bipolarisme russo-américain dans la perspective de la ‘Grande Europe’, de l’Atlantique aux Ourals; b) contacts avec les forces du gaullisme et du neutralisme eurasien qui se proposaient cette ligne internationaliste” (2).
Trois ans après, en 1977, je lus dans le bulletin “Correspondance Européenne”, dirigé par Yves Bataille, un longue article intitulé L’URSS et la ligne géopolitique, qui semblait confirmer les bruits diffusés par quelques “dissidents” soviétiques au sujet de l’existence d’une mouvance pro-eurasienne agissant plus ou moins clandestinement de l’intérieur de l’Armée Rouge.
J’ai publié la traduction de cet article dans le premier numéro (janvier-avril 1978) d’une petite revue italienne qui s’appelait “Domani”.
L’auteur en était Jean Parvulesco, qui résumait dans la façon suivante les thèses fondamentales de certains milieux russes présentés comme “les groupes géopolitiques de l’Armée Rouge”, thèses exprimées dans une série de documents semi-clandestins arrivés en sa possession.
1. Le “Grand Continent” eurasiatique est un et indivisible, “de l’Atlantique au Pacifique”.
2. La politique européenne de la Russie soviétique ne saurait donc être qu’une politique d’unité continentale, solidaire avec une Europe intégrée autour de la France et de l’Allemagne.
3. L’unité du Gran Continent eurasiatique doit être poursuivie, aussi, à travers la mise en place d’une structure de relations économiques et politiques avec l’Afrique, le Monde Arabe, le Japon, l’Indonésie.
4. L’ennemi fondamental de l’unité géopolitique eurasiatique reste les Etats-Unis.
5. La mission historique de la Russie n’est pas terminée, elle ne fait que commencer.
Selon un “mince livret” cité dans l’article de Parvulesco, le jour de la mort de Staline trois saints staretz étaient partis à pied de Kiev, en assumant, chacun d’eux, la responsabilité apostolique du renouveau final de l’Orthodoxie dans une aire culturelle du Continent. Des trois staretz, Élie prit la Russie, Alexandre la “Grande Sibérie” e Jean l’Europe.
Ce dernier, Frère Jean, bien que poursuivi pendant des années par la Securitate roumaine, aurait produit par sa seule présence sur place le “changement intérieur” du régime communiste de Bucarest.
Pour soutenir cette affirmation, Parvulesco évoque le témoignage du roman Incognito de Petru Dumitriu, paru en 1962 chez les Éditions du Seuil.
Petru Dumitriu (1924-2002) a été un romancier roumain, dont le chef-d’oeuvre, Cronica de familie, a été également publié en France par Seuil, en 1959. En 1960, voyageant en Allemagne de l’Est, il passa clandestinement à Berlin Ouest et demanda asile politique aux autorités françaises, qui le lui refusèrent; il l’obtint en Allemagne Fédérale. Ensuite il vécut à Frankfurt et à Metz, où il mourut en 2002.
Le Frère Jean qui figure dans Incognito de Petru Dumitriu est vraisemblablement l’alter ego littéraire du moine russe Ivan Koulyguine (1885- ?), représentant d’un filon hésychaste remontant au grand staretz ukrainien Païssius Vélitchkovsky (1722-1794), qui vécut au XVIIIe siècle au monastère de Neamtz en Moldavie et ensuite à Optina Poustyne.
En novembre 1943 le Père Ivan Koulyguine s’était enfui de l’Union Soviétique avec le métropolite de Rostov et avait trouvé refuge dans le monastère Cernica, près de Bucarest. Appelé en Roumanie Ioan Străinul, c’est à dire Jean l’Étranger, le Père Ivan devint le guide spirituel du Buisson Ardent (“Rugul Aprins”), un groupe d’intellectuels roumains qui se proposait de ranimer la tradition hésychaste.
Ivan Koulyguine fut arrêté par les Soviétiques en octobre 1946; poursuivi en justice et condamné en janvier 1947 à dix ans de travaux forcés, il fut transféré en URSS, où l’on perdit sa trace.
Jean Parvulesco n’est pas le seul à parler d’un “changement intérieur” produit en Roumanie par l’action de Frère Jean, c’est à dire du Père Ivan.
Aussi Alexandru Paleologu, qui a été ambassadeur de la Roumanie à Paris, a écrit qu’après la libération des survivants du groupe du Buisson Ardent, qui eu lieu grâce à l’amnistie voulue par Gheorghiu-Dej, “les nouvelles générations, les jeunes assoiffés de Dieu, (…) devinrent, en quelque sorte, les témoins au deuxième degré d’un mouvement chrétien qui a su jouer un rôle encore plus important qu’on aurait pu le croire et qui, à la vérité, s’avérait être de ‘longue haleine’ et d’une influence profonde” (3).
Ensuite, j’ai trouvé l’état civil de Jean Parvulesco dans une fiche de la Securitate roumaine rédigée dans les années ’50, que je vais traduire:
“Jean Pîrvulescu, fils de Ioan et de Maria, né le 29 septembre 1929 à Piteşti, dernier domicile à Craiova, str. Dezrobirii n. 25. En 1948 il a disparu de son domicile et il a passé frauduleusement la frontière; en 1950 il a écrit de Paris, France, à ses proches en RPR. En 1956 on a signalé que, avec l’espion Ieronim Ispas, il était sur le point de venir en Roumanie sous couverture du rapatriement, en mission d’espionnage. Dans le cas où il est identifié, il doit être arrêté” (4).
Piteşti, la ville natale de Jean Parvulesco, se trouve au bord de l’Argeş, une rivière qui constitue le scénario d’une fameuse légende roumaine: la légende de Maître Manole, constructeur de ce monastère de Curtea de Argeş qui fut commissionné par Negru Voda, duquel la mère de Jean Parvulesco serait une descendante.
Piteşti est située très près de la région historique de l’Olténie, dont Craiova est la capitale. Dans cette même région se trouve la localité de Maglavit, où, depuis le 31 mai 1935, un berger illetré du nom de Petrache Lupu (1908-1994) était le destinataire des communications d’une entité qu’il appellait Moşul, c’est à dire “le Vieux”, et qui était considérée comme une sorte de théophanie. “À Maglavit et dans les alentours – rapporte la presse de l’époque – prévaut un état d’esprit complètement nouveau. Les gens ont accueili les exhortations de Petrache Lupu à chercher de s’imposer un type de vie différent” (5).
L’écho que ces événements ont en Roumanie (on parle de la “psychose de Maglavit”) conduit Emil Cioran à changer d’avis sur le scepticisme du peuple roumain et à placer ses espoirs en un prochain grand phénomène spirituel et politique. “On ne peut pas dire – écrit Cioran – ce qu’il sera; mais on peut dire que, s’il ne naît pas, nous sommes un pays condamné” (6).
Mihai Vâlsan (1911-1974) reçoit du voyant de Maglavit une sorte de “bénédiction” (binecuvântare); et, comme les messages du “Vieux” semblent annoncer aux Roumains que leur terre deviendra le siège d’un centre spirituel comme l’avait déjà été la Dacie dans l’antiquité, Vâlsan pense que tout cela a affaire avec le Roi du Monde. On connaît le développement de cette histoire.
Ce qui peut nous intéresser ici, c’est la position de Parvulesco face à ces deux Roumains d’expression française – Cioran et Vâlsan.
Pour ce qui est de Cioran, Parvulesco a dit dans un entretien avec Michel d’Urance paru dans “Éléments”: “Je porte encore en moi le deuil atroce que j’avais ressenti devant l’effroyable auto-mutilation que Cioran avait infligée à son génie profond, à son inspiration la plus intime, afin qu’il puisse se faire relativement admettre au banquet des noces démocratico-marxistes d’après la guerre – qui battait alors son plein. Le nihilisme de Cioran, aussi loin qu’il pût aller, n’avait jamais représenté un choix doctrinal, n’ayant en aucun cas constitué que le signe exacerbé d’un constat de désastre face à l’effondrement en cours de la civilisation européenne tout près de sa fin” (7).
Quant à Michel Vâlsan, Jean Parvulesco a dû voir en lui, dans quelque façon, l’intermédiaire secret entre l’enseignement de René Guénon et le Général De Gaulle.
Dans La spirale prophétique il se demande: “Quels sont (…) les rapports encore présents et les rapports à venir entre l’oeuvre de René Guénon et celle de Michel Vâlsan? Y a-t-il eu, y a-t-il, de l’une ou l’autre, la continuation d’un même ministère, exclusivement, ou bien l’oeuvre de Michel Vâlsan apparaît-elle, ou commencerait-elle à apparaître comme la proposition, comme le fruit ardente d’une spécification déjà differenciée?” (La spirale prophétique, p. 75). En tout cas, Parvulesco était convaincu de “l’existence d’une convergence voilée mais très profonde entre l’enseignement de René Guénon et les dimensions confidentielles, voire occultes, de l’action historique et transhistorique entreprise par Charles de Gaulle (…)” (8).
Si nous devions ajouter foi aux dires de Jean Robin, Michel Vâlsan aurait joué un rôle occulte auprès de “ce grand guénonien que fut le général de Gaulle” (9), rangé par Vâlsan lui-même – toujours selon Jean Robin – parmi les “préfigurations du Mahdi” (10) qui se sont manifestées au XXe siècle. Rapportant une information qu’il déclare avoir recueillie auprès de “certains disciples de Michel Vâlsan” (11), Jean Robin fait allusion à une correspondance épistolaire entre Vâlsan et le Général, ainsi qu’à une “mystérieuse initiation” que le premier aurait transmise au second dans les jardins de l’Élysée; il ajoute que Vâlsan était en mesure d’annoncer à l’avance à ses disciples les décisions de Charles de Gaulle y compris les moins prévisibles.
Cependant, Michel Vâlsan ne figure pas dans la liste des écrivains qui, selon ce que Parvulesco dit dans l’entretien paru dans “Éléments”, “ont le plus compté pour [lui], qui ont souterrainement nourri [son] oeuvre”. Il s’agit d’une liste de trente-six auteurs, parmi lesquels il y a Virgile et Dante, Rabelais et Pound, Gobineau et Saint-Yves d’Alveydre; on y trouve aussi Haushofer, Hamsun, Drieu La Rochelle, Céline, Guénon, Corbin, Heidegger.
Le seul compatriote que Parvulesco ait cité dans cette liste est “Basile Lovinesco”, c’est à dire ce Vasile Lovinescu (1905-1984) qui nous a donné l’exégèse hermétique de la légende de Maître Manole.
D’ailleurs, lorsque dans La spirale prophétique nous lisons la phrase sur les “remanences carpathiques de l’ancien culte du dieu Zamolxis” (12), c’est bien Vasile Lovinescu qui nous vient à l’esprit, avec son essai sur la “Dacie hyperboréenne”, écrit sous le pseudonyme de “Géticus” et originellement paru en français dans plusieurs livraisons de la revue “Études Traditionnelles” en 1936-1937.
Pour ce qui est de Mircea Eliade, dans l’entretien avec Michel d’Urance Jean Parvulesco dit que, selon une information qu’il avait reçu à la rédaction d’”Etudes”, Jean Daniélou aurait demandé à Eliade, sur instance du pontife Pie XII, de s’engager dans un travail intellectuel ayant pour but d’exposer une nouvelle vision de l’histoire des religions, pour combattre dans les milieux universitaires l’hégémonie culturelle du marxisme et de ses dérivés. L’engagement d’Eliade dans cette entreprise, observe Parvulesco dans l’entretien citée plus haut, “ne lui a plus permis de tellement s’occuper de littérature, alors que ses romans roumains d’avant la guerre, ainsi que ses nouvelles plus récentes, n’avaient pas cessé d’administrer la preuve éclatante de son extraordinaire vocation de romancier”.
Parvulesco nous dit que deux nouvelles d’Eliade, Minuit à Serampore et Le secret du Docteur Honigberger (respectivement parues en Roumanie en 1939 et en France chez Stock en 1956 et 1980), recèlent une conception tantrique occulte et interdite envisageant la suspension et le changement du cours et de la substance même de l’histoire (13).
Il nous dit encore que tous les grands romans roumains écrits par Eliade avant la guerre “instruisent pathétiquement le procès de cette génération [c'est à dire la "nouvelle génération" roumaine entre les deux guerres mondiales, génération, il dit,] de hauts mystiques sacrifiés dans un dessein très occultement providentiel, et qui eurent à subir, en quelque sort, l’épreuve de l’immolation sanglante jusqu’à l’avoir eux-mêmes inexorablement attirée sur eux” (14).
Parmi les romans éliadiens d’avant-guerre, c’est surtout Le retour du Paradis (Întoarcerea din rai) qui a touché Parvulesco, et cela à cause d’une citation poétique insérée dans ce texte. Il écrit: “C’est en lisant, adolescent encore, Le retour du Paradis de Mircea Eliade que j’avais en effet pris conscience des pouvoirs suprahumains contenus dans un hymne orphique de Dan Botta, qui s’y trouvait cité (sans doute très à dessein, je ne le sais plus). Quarante ans après, des fragments de l’hymne orphique de Dan Botta viennent me hanter encore. (…) Ce fut à l’instant même de la première lecture de l’hymne orphique de Dan Botta que Chidher le Vert est venu se saisir de moi, porté par le sommet d’une immense vague de lumière verte, supracosmique, lumière fondamentale (…) de la Voie Deltaïque, qui concerne l’humanité dans les cycles de son devenir impérial occulte d’avant et d’après le cycle actuel, Voie Deltaïque régie, dans les abîmes, par la divine Una, la jeune femme verte, la vierge supracosmique dont le nom et la figure irradiante se perpétuent irrationnellement dans les remanences carpathiques de l’ancien culte du dieu Zamolxis” (15).
Le roumain Dan Botta (1907-1958), poète, dramaturge, essayiste, philologue, traducteur de Sophocle, Euripide, Shakespeare, Villon et Poe, appartenait à la “nouvelle génération” et adhéra au mouvement légionnaire; il fut membre du comité de direction de l’Encyclopédie Roumaine et fonda en 1941 la revue “Dacia”.
Comme poète, il débuta en 1931 avec un volume de vers intitulé Eulalii et préfacé par Ion Barbu (1895-1961), dans lequel se trouve la plus célèbre de ses créations poétiques, Cantilena, écrite dans les formes et les rythmes d’une poésie populaire. Or, l’”hymne orphique de Dan Botta” est justement Cantilena et le passage cité par Eliade qui a hanté longuement Jean Parvulesco est le suivant:
Pe vântiri ascult
Orficul tumult
(…)
Oh, mă cheamă-ntruna
Palida nebuna
Fata verde Una,
Şi-n mine se strânge
Piatra ei de sânge…
Parvulesco nous en donne une belle traduction, un peu libre, faite vraisemblablement par lui même:
exposé sur les hauts vents
un orphique tumulte j’entends
quand elle dresse soudain sa lyre,
la fille verte de mon délire
Una, et qu’en moi se tend
la pierre rouge de son sang.
Dans le même chapître du Retour du Paradis où sont cités les vers de Cantilena, quelques personnages du roman d’Eliade essayent de comprendre pourquoi la femme aimée par le protagoniste, Anicet, porte le nom de Una; l’un d’eux pense à la Junon des Etrusques, qui s’appellait Uni, tandis qu’un autre pense au Dialogue entre Monos et Una de Edgar Poe. Mais on n’arrive pas à une explication conclusive.
En 1960, vingt-six ans après la publication du Retour du Paradis, Mircea Eliade est revenu sur les vers de Cantilena, écrivant dans une revue de l’émigration roumaine: “Pour Dan Botta, le monde devenait réel quand il commençait à révéler ses structures profondes; c’est à dire, quand l’oeuil de l’esprit commence à saisir, derrière les apparences, les images éternelles, les figures mythiques. Tu pénétrais dans le mystère d’une nuit d’été quand tu arrivais à te la révéler comme dans ces vers de Cantilena: ‘Pe vântiri ascult – Orficul tumult – Când şi ardică struna – Fata verde, Una, – Duce-i-aş cununa…‘ Alors le cosmos entier dévoilait ses significations profondes, car le vent, la lune étaient la chiffre de mythes et drames anciens, qui faisaient déjà partie de l’histoire spirituelle de l’homme. Plus exactement: de l’homme balcanique, entendant par ce terme ethno-géographique toute l’Europe de l’est (…) Dan Botta avait un faible pour ce territoire (…) Dans une certaine façon c’était une géographie sacrée, parce que sur ces plaines et ces montagnes les hommes avaient rencontré Apollon et Dionysos, Orphée et Zamolxis” (16).
La relation entre la suprême divinité des Daces et l’activité de Eliade a été soulignée par Jean Parvulesco, qui, à propos des “remanences carpathiques de l’ancien culte du dieu Zamolxis”, écrit: “D’ailleurs, juste avant la dernière guerre, Mircea Eliade n’avait-il pas commencé l’édition d’une collection de cahiers de l’histoire des religions intitulée, précisément, Zamolxis ?” (17).
Pour revenir à la “fille verte Una”, il faut citer un autre passage de La spirale prophétique, qui est le suivant: “Je rappelle que, dans certains groupements spirituels des plus spéciaux et actuellement des plus retirés, c’est le 7 juillet [rappellez cette date] que des rassemblements se font, à l’abri du plus parfait secret, pour célébrer la ‘déesse verte’ Una, l”infiniment absente, l’infiniment lointaine, l’infiniment silencieuse mais qui, bientôt, ne le sera plus’ ” (18).
Dans “la fille verte Una” (fata verde Una) évoquée par Dan Botta, Eugène Ionesco y a vu une épiphanie de Diane rattachable à la mythologie légionnaire, probablement parce que la couleur verte était la couleur symbolique de la Garde de Fer.
Mais il faut dire, aussi, qu’en Dacie on a trouvé des nombreuses inscriptions dédiées à Diane (Diana regina, vera et bona, mellifica), avec laquelle a été identifiée une divinité traco-gétique.
Il faut ajouter que le nom latin de Diana a produit en roumain le mot zână, qui signifie “fée”, tandis que Sancta Diana a donné origine à la forme plurielle Sânziene. Le Sânziene sont fêtées dans la nuit du 24 juin, une fête solsticiale qui coïncide avec la nativité de Saint Jean le Baptiste. C’est précisement cette nuit la “nuit d’été” que Eliade – dans le passage que je viens de vous lire – a mis en relation avec les vers de Cantilena qui hantaient Jean Parvulesco.
Je rappelle aussi que Noaptea sânzienelor, “La nuit des fées”, est le titre d’un roman de Mircea Eliade (publié en 1955 chez Gallimard avec le titre de Forêt interdite), où le protagoniste, Ştefan Viziru, se trouve emprisonné avec les légionnaires à Miercurea Ciuc, exactement comme le fut Mircea Eliade.
Or, Jean Parvulesco a écrit un texte mystique qui s’appelle Diane devant les Portes de Memphis, imprimé exactement le 7 juillet 1985 et présenté comme une liturgie de Diane.
Qui est donc cette Diane célébrée par Jean Parvulesco? D’après ce qu’il dit, on la peut l’identifier avec la mystérieuse “femme couverte de soleil, la lune sous ses pieds et couronnée dedouze étoiles” (19) qui se tient, dit Parvulesco, au centre de la future civilisation impériale eurasiatique.
Ici il faut donc souligner une autre convergence essentielle entre Mircea Eliade et Jean Parvulesco. C’est leur commune reconnaissance du destin unitaire du Continent eurasien. Dans ses entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Eliade déclarait avoir découvert qu’en Europe “les racines sont bien plus profondes que nous l’avions cru (…) Et ces racines nous révèlent l’unité fondamentale non seulement de l’Europe, mais aussi de tout l’ékoumène qui s’étend du Portugal à la Chine et de la Scandinavie à Ceylan” (20).
Presque simultanément, Jean Parvulesco s’engageait dans les voies de l’avènement de la nouvelle Europe grande-continentale, de l’ « Empire Eurasiatique de la Fin ».
1. Fiasconaro e Alessandrini accusano. La requisitoria su la strage di Piazza Fontana e le bombe del ’69, Marsilio, Padova 1974, p. 231.
2. Fiasconaro e Alessandrini accusano, cit., p. 142.
3. André Paléologue, Le renouveau spirituel du “Buisson Ardent”, “Connaissance des Religions”, avril 1990, p. 132.
4. Mihai Pelin, Culisele spionajului românesc. D.I.E. [Direcţia de Informaţii Externe] 1955-1980, Editura Evenimentul Românesc, Bucarest 1997, p. 42.
5. H. Sanielevici, Rasa lui Petrache Lupu din Maglavit, “Realitatea Ilustrată”, IXe année, n. 447, 14 août 1935.
6. E. Cioran, Maglavitul şi cealalta Românie, “Vremea”, VIIIe année, n. 408, 6 octobre 1935, p. 3.
7. Jean Parvulesco: “Une conscience d’au-delà de l’histoire”. Propos recueillis par Michel d’Urance, “Éléments”, 126, Automne 2007, pp. 54-57.
8. Jean Parvulesco, La spirale prophétique, Guy Trédaniel, Paris 1986, p. 76.
9. Jean Robin, René Guénon. La dernière chance de l’Occident, Guy Trédaniel, Paris 1983, p. 9.
10. Jean Robin, Les Sociétés secrètes au rendez-vous de l’Apocalypse, Guy Trédaniel, Paris 1985, p. 211.
11. Jean Robin, Les Sociétés secrètes au rendez-vous de l’Apocalypse, cit., p. 335.
12. Jean Parvulesco, La spirale prophétique, cit., p. 325.
13. Jean Parvulesco, La spirale prophétique, pp. 255-256.
14. Jean Parvulesco, La spirale prophétique, pp. 324-325.
15. Jean Parvulesco, La spirale prophétique, p. 325.
16. Mircea Eliade, Fragment pentru Dan Botta, “Prodromos”, 7, juillet 1967, p. 21.
17. Jean Parvulesco, La spirale prophétique, pp. 325-326.
18. Jean Parvulesco, La spirale prophétique, pp. 328.
19. Jean Parvulesco: “Une conscience d’au-delà de l’histoire”. Propos recueillis par Michel d’Urance, cit., p. 53.
20. Mircea Eliade, L’épreuve du labyrinthe. Entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Pierre Belfond, Paris 1978, p. 70.