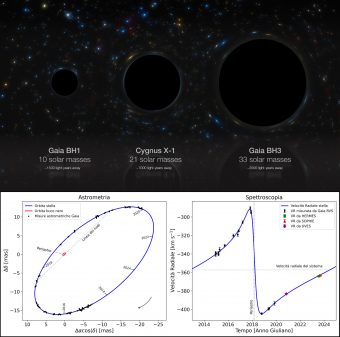Russia Today, 9 Novembre 2012
SOPHIE SHEVARNADZE: Signor Presidente, grazie di averci concesso questa intervista.
BASHAR AL-ASSAD: Benvenuti a Damasco.
SOPHIE SHEVARNADZE: Un anno fa, molti erano convinti che non si sarebbe arrivati fino a questo punto. Noi, però, stiamo registrando questa intervista nel Palazzo presidenziale che è stato restaurato di recente. Chi è oggi esattamente il Suo nemico?
BASHAR AL-ASSAD: I miei nemici sono il terrorismo e l’instabilità in Siria. È questo il vero pericolo in Siria. Non è la gente, non sono le persone. Il vero problema non è se vado o se resto, il problema è la sicurezza del Paese. Questo è il nemico che abbiamo combattuto.
SOPHIE SHEVARNADZE: Io sono stata qui in questi due ultimi giorni e ho avuto la possibilità di parlare con qualche persona di Damasco. Alcuni ritengono che il fatto che Lei parta o meno, adesso, non è più veramente importante. Cosa ne pensa?
BASHAR AL-ASSAD: Penso che la partenza di un Presidente sia una decisione che spetta al popolo e non una scelta personale. Il solo modo per conoscerla è passare attraverso l’esito delle urne. Dunque, questa questione non ha niente a che fare con quello che si desidera, ma ha a che fare con quello che diranno le urne. E le urne, solo le urne, diranno a qualunque Presidente se debba andare o restare. Molto semplicemente.
SOPHIE SHEVARNADZE: D’ora in avanti il bersaglio non è più Lei, ma la Siria.
BASHAR AL-ASSAD: Non ero io il bersaglio, non ero io il problema. Ad ogni modo, Lei lo sa bene, l’Occidente crea dei nemici. In precedenza per differenti ragioni è stato il comunismo, poi è diventato l’Islam, poi Saddam Hussein. Adesso si vorrebbe creare un nuovo nemico: dicono che Bashar Al-Assad è il problema e che deve andarsene. È per questo motivo che noi dobbiamo concentrarci sul problema reale senza perder tempo ad ascoltare quel che dicono.
SOPHIE SHEVARNADZE: Ma, personalmente, pensa ancora di essere il solo uomo capace di tenere insieme la Siria e mettere fine a quella che il mondo chiama “guerra civile”?
BASHAR AL-ASSAD: Si può affrontare la questione da differenti punti di vista. Primo, la Costituzione, dalla quale traggo la mia autorità. Stando a questa autorità e a quanto dice la Costituzione, io devo essere capace di risolvere il problema. Ma ponete l’attenzione sul fatto che nessun altro siriano può essere Presidente. O meglio, qualunque siriano potrebbe esserlo e molti sono eleggibili per questa carica, ma non si può legare per sempre il Paese ad una sola persona.
SOPHIE SHEVARNADZE: Ma Lei si batte per il Suo Paese. Ritiene di essere l’uomo che può mettere fine al conflitto e riportare la pace?
BASHAR AL-ASSAD: Io devo essere l’uomo che può farlo e spero di farlo. Ciò non è collegato al potere del Presidente, ma concerne tutta la società. Bisogna essere precisi: il Presidente non può fare niente senza le istituzioni e il sostegno del popolo. Non si tratta della battaglia del Presidente, ma della battaglia dei Siriani. Attualmente, ciascun siriano sta difendendo il suo Paese.
SOPHIE SHAVARNADZE: Effettivamente, siccome molti civili stanno morendo anche in combattimento, se Lei vincerà la guerra, dopo tutto quel che è successo, come si riconcilierà con il Suo popolo?
BASHAR AL-ASSAD: Il problema non è tra me e il popolo, non ho dei problemi con il popolo, ma il problema è che gli Stati Uniti sono contro di me, l’Occidente è contro di me, molti Paesi arabi e la Turchia sono contro di me. Il popolo siriano è contro di me allo stesso modo? Allora perché io sono ancora al mio posto?
SOPHIE SHEVARNADZE: Non è quindi contro di Lei?
BASHAR AL-ASSAD: Se il mondo intero, o diciamo la maggior parte del mondo compreso il vostro popolo, è contro qualcuno, questo qualcuno sarebbe un supereroe!?! Sarebbe solo un uomo. Ciò non ha logica. Non si tratta di riconciliazione col popolo, né tra Siriani e Siriani. Non c’è guerra civile in Siria. Il problema è il terrorismo e il loro finanziamento proveniente dall’esterno del Paese per destabilizzare la Siria. Ecco la nostra guerra.
![1]()
Bashar Al-Assad mentre parla con Sophie Shevardnadze di Russia Today
SOPHIE SHEVARNADZE: Lei non crede alla guerra civile, anche se io so che, a parte il terrorismo che tutto il mondo riconosce, ci sono molti conflitti d’idee. Per esempio, tutti abbiamo sentito parlare della madre di due figli: uno che si batteva per le forze governative e l’altro per le forze ribelli. Non è un guerra civile?
BASHAR AL-ASSAD: Ci sono delle divisioni, ma questo non vuol dire “guerra civile”. È del tutto diverso. Una guerra civile nasce da problemi etnici e settari. Si possono avere talvolta delle tensioni etniche o settarie, ma ciò non significa che esista un problema. Dunque, se ci sono delle tensioni nella stessa famiglia, in una grande tribù, o nella stessa città, non si tratta necessariamente di una guerra civile, ma di una cosa differente e normale. Ce lo dobbiamo aspettare.
SOPHIE SHEVARNADZE: Quando Le ho fatto la domanda circa la conciliazione con il Suo popolo intendevo proprio questo. La ho sentita ripetere in molte occasioni che la sola cosa che Le importa sono il pensiero e i sentimenti che i Siriani nutrono nei Suoi confronti. Non hae paura che alla fine, visto il danno patito dal Paese, il popolo non avrà più voglia di ricercare la verità e semplicemente La accuserà di tutto quello che ha sofferto?
BASHAR AL-ASSAD: Questione ipotetica, poiché quello che il popolo pensa è giusto. Noi dobbiamo, quindi, domandargli che cosa pensi, ma non ho questa informazione in questo momento. Ma, ancora una volta, non ho paura di quello che pensano di me; io ho paura per le sorti del mio Paese, abbiamo bisogno di concentrarsi su questo.
SOPHIE SHEVARNADZE: Nel corso degli anni si sono rincorse storie a proposito della potenza militare della Siria, dei servizi segreti importanti, ma adesso noi vediamo che le forze governative non sono capaci di battere il nemico come ci si attendeva. Assistiamo ad attacchi terroristici al centro di Damasco praticamente tutti i giorni. Era tutta una leggenda?
BASHAR AL-ASSAD: In circostanze normali, ci concentreremmo sul nemico esterno e, anche se esiste un nemico interno rappresentato dal terrorismo, la società aiuta almeno a non incubare al suo interno dei terroristi. Ma in questo caso assistiamo ad un nuovo tipo di guerra: il terrorismo per procura. Sia di Siriani che vivono in Siria, sia di stranieri che vengono dall’esterno. Noi dobbiamo adattarci a questo tipo di guerra, non è facile e ci vuole tempo. Non possiamo dire che sia come combattere una guerra normale. No, è molto più difficile.
In secondo luogo, il sostegno offerto ai terroristi in tutti i campi (armi, soldi, sostegno politico) è senza precedenti. Dobbiamo aspettarci una guerra dura e difficile. Non si può pretendere che un piccolo Paese come la Siria possa battere in qualche giorno o qualche settimana tutti quei paesi che combattono per procura: da una parte abbiamo un capo con una forza armata cui ordina di andare dritto, a sinistra, a destra, e questa obbedisce. Dall’altra, frange di terroristi non unificati e senza strategia che combattono contro di noi.
SOPHIE SHEVARNADZE: Quindi, come si combatte concretamente?
BASHAR AL-ASSAD: Il problema è che questi terroristi si battono all’interno delle città dove si trovano i civili. Quando si combatte contro terroristi di questo genere, è inevitabile un minimo di danni alle infrastrutture ed ai civili. Ma si deve pur combattere, non si può solo lasciare che i terroristi uccidano e distruggano tutto. In questo risiede la difficoltà di questa tipolo di guerra.
SOPHIE SHEVARNADZE: L’economia e le infrastrutture militari soffrono, è come se la Siria stia andando piuttosto presto verso la rovina ed il tempo è contro di voi. A Suo avviso, quanto tempo ci vorrà per vincere il nemico?
BASHAR AL-ASSAD: Non si può rispondere a questa domanda, visto che nessuno può dire quando la guerra avrà fine, a meno che non si sappia quando smetteranno di inviare dei combattenti dal mondo intero, soprattutto dal Medio Oriente e dal mondo islamico, e quando decideranno di smetterla di inviare armi a questi terroristi. Quando cesseranno queste attività, allora potremo dare una risposta alla domanda. Le potrei dire che entro poche settimane tutto sarà risolto, non è questo il problema. Ma finché si dispone di un approvvigionamento continuo di uomini, armi, logistica e tutto il resto, sarà una guerra a lungo termine.
![2]()
Bashar Al-Assad mentre parla con Sophie Shevardnadze di Russia Today
SOPHIE SHEVARNADZE: Allo stesso tempo ci sono 4000 km di frontiera poco controllati. Il nemico può in ogni momento attraversare la frontiera verso la Giordania o la Turchia per riarmarsi, ottenere assistenza medica e tornare a battersi contro di voi.
BASHAR AL-ASSAD: Esattamente, nessun paese al mondo può sigillare le proprie frontiere. Spesso si usa questa espressione, ma è impropria. Gli stessi Stati Uniti non possono sigillare la loro frontiera con il Messico, per esempio. La stessa cosa accade con la Russia, che è un grande Paese. Quindi, nessun Paese può sigillare le proprie frontiere: si può avere una buona situazione alle frontiere se si hanno buone relazioni con i vicini, cosa che attualmente non abbiamo, almeno non con la Turchia. La Turchia appoggia il contrabbando di armi e di terroristi più di ogni altro Paese.
SOPHIE SHEVARNADZE: Posso farle una domanda? Sono stata in Turchia di recente e la gente là ha paura di una guerra tra Siria e Turchia. Pensa che una guerra contro la Turchia possa essere uno scenario realistico?
BASHAR AL-ASSAD: Razionalmente riteniamo di no, per due motivi: una guerra richiede un sostegno pubblico e la maggioranza dei Turchi non ha bisogno di questa guerra. Penso che nessun politico dotato di buon senso possa andare contro la volontà del proprio popolo; la stessa cosa vale per la Siria. Il conflitto non è tra i popoli siriano e turco, ma tra il nostro governo ed il loro, a causa della loro condotta politica. Io non vedo, dunque, nessuna guerra all’orizzonte tra Siria e Turchia.
SOPHIE SHEVARNADZE: Quando ha parlato l’ultima volta con Erdogan?
BASHAR AL-ASSAD: Nel maggio del 2011, dopo che aveva vinto le elezioni.
SOPHIE SHEVARNADZE: Dunque gli ha fatto le felicitazioni?
BASHAR AL-ASSAD: Si, è stata l’ultima volta.
SOPHIE SHEVARNADZE: Chi ha bombardato la Turchia? I ribelli o il governo?
BASHAR AL-ASSAD: Per avere una risposta e sapere chi ha bombardato, c’è bisogno di un comitato congiunto tra i due eserciti, visto che alle frontiere molti terroristi hanno i mortai e possono benissimo essere stati loro. Bisognerebbe fare un’inchiesta sulla bomba, sul luogo, ma ciò non ha avuto seguito. Abbiamo chiesto al governo turco di costituire questo comitato, ma loro hanno rifiutato e quindi non possiamo avere una risposta. Ma quando si hanno i terroristi alle frontiere non si può escludere il fatto che siano stati loro, dal momento che l’esercito siriano non ha mai ricevuto l’ordine di bombardare il territorio turco. E’ un obiettivo che non ha alcun interesse per quel che ci riguarda, non c’è nessuna ostilità verso il popolo turco. Noi li consideriamo come dei fratelli, perché dunque fare una cosa del genere? A meno che ciò non sia avvenuto per errore ed è per questo che c’è bisogno di un un’inchiesta.
![3]()
Bashar Al-Assad mentre parla con Sophie Shevardnadze di Russia Today
SOPHIE SHEVARNADZE: Ammette che possa essere accaduto per errore? Per errore delle forze governative?
BASHAR AL-ASSAD: Potrebbe. Si tratta di una possibilità, ci sono errori in tutte le guerre. Per esempio, in Afghanistan, chi uccide un soldato che combatte con lui parla sempre di “fuoco amico”. Ciò significa che può accadere in tutte le guerre. Finora però non si può dire che sia questo il caso.
SOPHIE SHEVARNADZE: Per quale motivo la Turchia, che Lei dice essere una “Nazione amica”, è diventata la roccaforte dell’opposizione?
BASHAR AL-ASSAD: Non la Turchia. Solo il governo Erdogan, per essere precisi. Il popolo turco vuole avere un buon rapporto con il popolo siriano. Una delle ragioni è questa: Erdogan pensa che, se i Fratelli Musulmani prendono il potere nella regione, soprattutto in Siria, ciò potrà garantire il suo futuro politico. L’altro motivo: personalmente ritengo che egli pensi di essere il nuovo sultano ottomano e di poter controllare la regione così come è avvenuto ai tempi dell’Impero Ottomano, sotto un nuovo “ombrello” che è l’islamismo e non l’Impero Ottomano; non per diventare il califfo, anche se in cuor suo Erdogan pensa di esserlo. Queste le due ragioni principali per cui egli ha cambiato la sua politica da “zero problemi” a “zero amici”.
SOPHIE SHEVARNADZE: Ma non c’è solo l’ Occidente che si oppone a voi, avete molti nemici anche nel mondo arabo. Due anni fa, se qualcuno nel mondo arabo vi sentiva nominare, avrebbe stretto più forte i legami, mentre adesso alla prima occasione vi tradiscono. Come mai avete tanti nemici nel mondo arabo?
BASHAR AL-HASSAD: Non sono dei nemici: la maggior parte dei governi arabi in cuor loro sostengono la Siria, ma non osano dichiararlo apertamente.
SOPHIE SHEVARNADZE: Per quale motivo?
BASHAR AL-HASSAD: La pressione dell’Occidente e talvolta i petrodollari del mondo arabo.
SOPHIE SHEVARNADZE: Chi vi sostiene nel mondo arabo?
BASHAR AL-HASSAD: Molti paesi sostengono la Siria, ma non lo dicono esplicitamente. In primis l’Iraq, che ha giocato un ruolo molto attivo nel sostegno alla Siria durante la crisi, perché è un Paese vicino e perché in Iraq sanno che se c’è la guerra in Siria potrebbe esserci in futuro la guerra anche nei Paesi vicini, compreso l’Iraq. Altri Paesi tengono una buona posizione verso la Siria, come l’Algeria e l’Oman. Anche altri Paesi hanno posizioni positive, ma senza essere attivi nel conflitto.
SOPHIE SHEVARNADZE: Perché Arabia Saudita e Qatar sono così categorici sulle vostre dimissioni e in che modo un Medio Oriente instabile potrà entrare nella loro agenda?
BASHAR AL-ASSAD: Molto francamente, non posso rispondere a loro nome, solo loro possono rispondere a questa domanda. Ma quello che posso dire è che il problema tra la Siria e gli altri Paesi, siano del mondo arabo, nella regione o in Occidente, è che noi continuiamo a dire “no” quando pensiamo di dover dire di “no”. Questo è il problema. E certi Paesi pensano di poter controllare la Siria attraverso degli ordini, dei soldi o dei petrodollari. Questo è impossibile in Siria. Se vogliono giocare un ruolo non ci sono problemi. Che se lo meritino oppure no, possono giocare un ruolo. Ma non a scapito dei nostri interessi.
![4]()
Bashar Al-Assad mentre parla con Sophie Shevardnadze di Russia Today
SOPHIE SHEVARNADZE: Ma l’obiettivo è quello di controllare la Siria? O di esportare la loro versione dell’Islam in Siria?
BACHAR AL-ASSAD: Si può dire che talvolta è la politica di un governo. Alle volte ci sono delle istituzioni o delle persone che promuovono questa linea politica, ma non la dichiarano linea politica ufficiale. Loro non ci hanno chiesto di promuovere, diciamo, i loro atteggiamenti estremisti verso le istituzioni. In realtà, però, succede così, sia attraverso il sostegno indiretto del loro governo, sia attraverso la creazione di istituzioni e di personale. Ciò fa parte del problema. Quando parlo come governo, dovrei menzionare la politica annunciata. La linea politica ufficiale è come qualsiasi altra politica, si tratta di interessi, di giocare un ruolo e non possiamo ignorare quello che lei ha detto.
SOPHIE SHEVARNADZE: L’Iran, che è un alleato molto vicino, è ugualmente esposto a delle sanzioni economiche e fa fronte allo stesso modo ad una minaccia di invasione militare. Se vi troverete a confrontarvi con la possibilità di tagliare i vostri legami con l’Iran in cambio della pace nel vostro Paese, lo farete?
BACHAR AL-ASSAD: Abbiamo avuto buone relazioni con l’Iran dal 1979 fino ad ora e sono sempre migliori ogni giorno che passa. Ma allo stesso tempo noi andiamo verso la pace, noi abbiamo un processo verso la pace e delle negoziazioni per la pace. L’Iran non è un fattore che gioca contro la pace. C’è della disinformazione: si sta cercando di promuovere in Occidente il fatto che se abbiamo bisogno della pace non abbiamo bisogno di buone relazioni con l’Iran. Tra le due cose non ci sono relazioni. L’Iran ha sostenuto la nostra causa, la causa dei territori occupati e noi dobbiamo sostenere la loro. Semplice. L’Iran per la regione è un Paese molto importante. Se ricerchiamo la stabilità, dobbiamo avere dei buoni rapporti con l’Iran. Non possiamo parlare di stabilità se non riusciamo ad avere buone relazioni con l’Iran, la Turchia e gli altri nostri vicini.
SOPHIE SHEVARNADZE: Avete delle informazioni sul fatto che i servizi segreti occidentali finanziano dei combattenti ribelli qui in Siria?
BACHAR AL-ASSAD: No. Quello che sappiamo finora è che forniscono un sostegno ai terroristi per quel che riguarda le conoscenze, attraverso la Turchia e talvolta attraverso il Libano, per lo più. Ma ci sono degli altri servizi segreti, non occidentali, ma regionali che sono molto attivi, più di quelli occidentali, sotto la supervisione dei servizi di informazione occidentali.
SOPHIE SHEVARNADZE: Qual è stato il ruolo di Al Qaeda in Siria finora? Controlla alcune forze della coalizione dei ribelli?
BACHAR AL-ASSAD: Non penso che cerchino di controllare. Vogliono i loro regni o emirati nella propria lingua, ma attualmente stanno provando principalmente a terrorizzare la gente attraverso esplosioni, omicidi, attentati suicidi e cose del genere, per spingere la gente alla disperazione e accettare la realtà per quella che è. Vanno dunque avanti una tappa alla volta verso l’obiettivo finale, che è il cosiddetto Emirato Islamico di Siria, da dove poter promuovere la loro ideologia nel resto del mondo.
SOPHIE SHEVARNADZE: Tra coloro che si battono contro di voi e sono contro di voi, a chi parlereste?
BASHAR AL-ASSAD: Noi parliamo a chiunque abbia il desiderio autentico di aiutare la Siria e non perdiamo il nostro tempo con chiunque voglia utilizzare la crisi siriana per i propri interessi.
![5]()
Bashar Al-Assad mentre parla con Sophie Shevardnadze di Russia Today
SOPHIE SHEVARNADZE: Ci sono state spesso accuse, non contro di Lei, ma contro le forze governative, di crimini di guerra contro i civili stessi. E’ d’accordo che le forze governative hanno commesso crimini di guerra contro i civili?
BASHAR AL-ASSAD: Noi ci battiamo contro il terrorismo, mettiamo in opera i dettami della nostra Costituzione e proteggiamo il popolo siriano. Ritorniamo a quello che è successo in Russia dieci anni fa: si combatteva il terrorismo in Cecenia e altrove, dove i terroristi hanno attaccato teatri, scuole… e l’esercito russo ha protetto il popolo. Dite che è stato un crimine di guerra? No… Due giorni fa, Amnesty International ha riconosciuto i crimini di guerra commessi qualche giorno prima dall’esercito dei ribelli, quando hanno catturato dei soldati e li hanno condannati a morte per esecuzione. Human Rights Watch ha ripetutamente denunciato i crimini di questi gruppi terroristici. Questo è il primo punto. In secondo luogo, avere un esercito che compie crimini contro il suo popolo è privo di logica: l’esercito siriano è composto dal popolo siriano. Se ordinaste di commettere dei crimini contro il vostro stesso popolo, l’esercito si dividerebbe, si disintegrerebbe. In terzo luogo, in Siria l’esercito non può resistere per venti mesi in condizioni difficili senza un sostegno popolare. Come ci può essere questo sostegno se uccidi la tua gente? Ciò è contraddittorio. Ecco la mia risposta.
SOPHIE SHAVARNADZE: Quando ha parlato per l’ultima volta a dirigenti occidentali?
BASHAR AL-ASSAD: Prima della crisi.
SOPHIE SHAVARNADZE: Ad un certo momento, hanno provato a dirLe che, se voi avesse lasciato il Suo posto, allora ci sarebbe stata la pace in Siria?
BASHAR AL-ASSAD: No, non direttamente. Ma direttamente o indirettamente, si tratta di una questione di sovranità e solo il popolo siriano può parlare di questo. Chiunque parli attraverso i media, in una dichiarazione, direttamente o indirettamente, non ha senso e nessun peso in Siria.
SOPHIE SHAVARNADZE: All’estero si dice che anche nel caso in cui decidesse di lasciare la Siria non avrebbe un posto dove andare. Dove andrebbe?
BASHAR AL-ASSAD: In Siria. Andrei dalla Siria in Siria. È il solo posto dove posso vivere. Non sono una marionetta. Non sono stato creato dall’Occidente per andare in Occidente o in qualsiasi altro Paese. Io sono Siriano, fatto in Siria, io devo vivere e morire in Siria.
![6]()
Bashar Al-Assad mentre parla con Sophie Shevardnadze di Russia Today
SOPHIE SHAVARNADZE: Pensa che a questo punto potrebbe esserci una possibilità per una discussione e per la diplomazia oppure adesso solo l’esercito può fare qualcosa?
BASHAR AL-ASSAD: Ho sempre creduto nella diplomazia e nel dialogo anche con persone che non ci credono. Dobbiamo continuare a provare. Se riuscirà o meno, dobbiamo sempre cercare un successo parziale. Bisogna cercare un successo parziale prima di aspettare un successo completo anche se bisogna essere realisti: non possiamo pensare che il solo dialogo possa permetterci di realizzare qualcosa, poiché le persone che hanno commesso questi atti sono di due tipi: primo, coloro che non credono al dialogo, soprattutto gli estremisti e i fuorilegge incriminati anni prima della crisi, per i quali il governo è il nemico naturale dal momento che sarebbero imprigionati se in Siria ci fosse una situazione normale; la seconda categoria è quella di coloro che sono sostenuti dall’estero. Essi si sono impegnati con persone che li pagano e li riforniscono di armi. Dobbiamo essere realisti. Ma c’è anche la terza categoria, quella di coloro che sono o attivisti o politici che accettano il dialogo. Questo è il motivo per cui abbiamo continuato il dialogo per mesi, anche con i militanti, e molti di loro hanno lasciato cadere le armi e sono tornati alla loro vita normale.
SOPHIE SHAVARNADZE: Pensa che un’invasione di una forza straniera sia imminente?
BASHAR AL-ASSAD: Credo che il prezzo di questa invasione sarà più alto di quello che il mondo possa permettersi, perché se ci sono dei problemi in Siria – e noi siamo l’ultimo baluardo della laicità e della stabilità nella regione – ci sarà un effetto domino dall’Atlantico al Pacifico e si conoscono le implicazioni sul resto del mondo. Non penso che l’Occidente imboccherà questa strada; ma, nel caso, nessuno è in grado di dire cosa succederà.
SOPHIE SHAVARNADZE: Presidente, si sente in colpa per qualcosa? Quale è stato il Suo errore più grande?
BASHAR AL-ASSAD: Sul momento, ad essere franchi, non saprei. Anche prima di prendere una decisione considero sempre il fatto che una parte sarà sbagliata, ma non si può parlare subito degli errori. Talvolta, soprattutto durante le crisi, non si vede ciò che è giusto o sbagliato. Non sarei, dunque, oggettivo nel parlare di errori adesso, perché siamo ancora nel bel mezzo della crisi.
SOPHIE SHAVARNADZE: Al momento quindi non ha rimpianti?
BASHAR AL-ASSAD: No. Quando tutto è chiaro si può parlare dei propri errori. Ma per forza di cose si commettono errori, è normale.
SOPHIE SHAVARNADZE: Se oggi fosse il 15 marzo 2011, giorno in cui le manifestazioni sono cominciate, cosa farebbe di diverso?
BASHAR AL-ASSAD: Farei quello che ho fatto il 15 marzo, esattamente la stessa cosa: chiederei alle diverse parti di avere un dialogo e di opporsi ai terroristi, perché è così che è cominciata. Non è cominciata con delle proteste. Le manifestazioni sono state l’ombrello, la copertura. Ma all’interno di queste manifestazioni alcuni militanti hanno cominciato a sparare sui civili e sull’esercito allo stesso tempo. Forse, a livello tattico, avremmo potuto fare alcune cose in modo diverso. Ma come Presidente non decido le tattiche, prendo sempre la decisione a livello strategico. La cosa è diversa.
SOPHIE SHAVARNADZE: Presidente Al-Assad, come vede se stesso tra dieci anni?
BASHAR AL-ASSAD: Vedo attraverso il mio Paese, io non mi vedo, io vedo il mio Paese tra dieci anni. È così che mi posso vedere.
SOPHIE SHAVARNADZE: Si vede in Siria?
BASHAR AL-ASSAD: Io devo essere in Siria. La mia posizione non è importante. Non mi vedo come presidente oppure no, non è questo che mi importa. Posso vedermi in questo Paese, un Paese sicuro, una Paese stabile e prospero.
SOPHIE SHAVARNADZE: Presidente siriano Bashar Al-Assad, grazie per averci concesso questa intervista.
BASHAR AL-ASSAD: Grazie ancora per essere venuti in Siria.
Traduzione di Andrea Turi